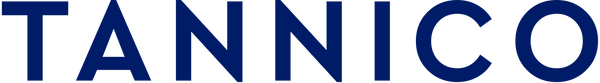Tannini del vino: cosa sono e a cosa servono?

Vigorosi, quasi graffianti, oppure più eleganti e setosi, i tannini sono una componente chiave del vino rosso. Responsabili del suo colore inconfondibile, che vira dal porpora al rubino, conferiscono corpo e struttura al prodotto. Ma cosa sono esattamente i tannini del vino? E come influenzano la degustazione? Cerchiamo di fare chiarezza.
Tannino: significato e ruolo biologico
Il termine tannino definisce una classe di composti appartenenti alla famiglia dei polifenoli, comuni in diverse piante e nei loro estratti. I tannini sono anche una componente naturale del vino, in quanto presenti in buone concentrazioni nell'uva, in particolare nelle bucce, nei vinaccioli e nel raspo.
Quelli rilasciati in fase di pressatura e macerazione del mosto vengono chiamati catechici o endogeni. I più pregiati, capaci di contribuire qualitativamente all’evoluzione in bottiglia, sono contenuti nelle bucce; di contro, quelli del raspo vengono generalmente scartati, in quanto amari e molto astringenti. Oltre a infondere le tanto apprezzate sfumature rosse, il tannino del vino migliora la conservazione e le caratteristiche organolettiche del prodotto stesso, favorendone la stabilità e l’integrità aromatica.
Tannicità del vino: da cosa dipende?
La tannicità di un vino è influenzata da molteplici fattori. Tra questi rientrano la varietà e il livello di maturità delle uve utilizzate, ma anche la tipologia di vinificazione scelta e i tempi di macerazione a contatto con le bucce. Il vitigno ha senza dubbio il suo peso: alcuni, come il Sagrantino, l’Aglianico e il Nebbiolo, sono infatti noti per l’elevata componente tannica. Tra i vini più tannici si contano anche quelli ottenuti da cultivar quali Tempranillo, Mourvèdre, Syrah e i grandi rossi di Bordeaux, primo fra tutti il Cabernet Sauvignon. È comunque l’invecchiamento in botte a determinare il profilo tannico definitivo del prodotto. Durante questa fase, grazie al microcircolo dell'ossigeno, il legno cede parte dei tannini gallici in esso contenuti, trasferendo al vino aromi e complessità olfattive. Le botti che rilasciano maggiori concentrazioni di tannini sono quelle in legno di rovere e di castagno. Anche l’età della botte incide in maniera significativa sull’equilibrio tannico: mentre in quelle vecchie i tannini risultano morbidi e rotondi, quelli ceduti dalle botti nuove si presentano più freschi ed evidenti.
Tannini: sono presenti nei vini bianchi?
Il contenuto in tannini del vino bianco è generalmente trascurabile. Oltre a risultare scarsamente presenti nelle uve a bacca bianca, occorre fare un'ulteriore considerazione: i tannini si concentrano soprattutto nella buccia, che, nella vinificazione dei bianchi, viene eliminata dal mosto prima della fermentazione. Fanno eccezione i vini fermentati in botte, soprattutto se di piccola capacità, come le barriques, che si arricchiscono dei tannini naturalmente contenuti nel legno. Anche i cosiddetti Orange wine presentano una discreta percentuale di tannini. Si tratta di vini prodotti con uve a bacca bianca, ma “vinificati in rosso”: il mosto viene lasciato macerare a contatto con le bucce, che quindi rilasciano questi particolari composti aromatici.
I tannini nella degustazione
Dal punto di vista sensoriale, la caratteristica più evidente dei tannini è l’astringenza. Questa classe di sostanze si lega infatti a proteine ricche di prolina, come quelle contenute nella saliva; quando le due sostanze si incontrano, il cavo orale perde temporaneamente le sue capacità lubrificanti. Al palato, si percepisce quindi una sensazione asciutta e legante, talvolta accompagnata da vaghi sentori amarognoli. Il sapore è simile a quello della mela cotogna, del carciofo crudo o di un caco poco maturo. I tannini del vino rosso preparano la bocca a piatti liquidi e succosi, abbinandosi alla perfezione a zuppe, brasati, carni in umido e arrosti ricchi di salse. Un vino il cui contenuto di tannini è talmente carente da determinarne fiacchezza gustativa, viene definito “molle”. All’opposto, quando la tannicità è eccessiva, si parla di astringenza, intesa come una durezza e una spigolosità spropositate. Come sempre, la virtù sta nel mezzo: un vino abbastanza tannico determina discrete sensazioni di secchezza e ruvidità, percepite come gradevoli al palato. È una caratteristica comune a molti vini rossi strutturati, sottoposti a un adeguato periodo di affinamento.
Tannicità del vino, una questione di tempo
C’è solo un modo per domare il carattere irruento e graffiante dei tannini giovani: l’invecchiamento del vino. Durante questa fase, che può durare pochi mesi o protrarsi per diversi anni, i tannini subiscono un processo ossidativo, che influenza in maniera significativa il carattere finale del prodotto. L’eleganza si raggiunge quindi col tempo: nel corso della maturazione, i tannini perdono via via la propria durezza e lasciano spazio a una loro versione più avvolgente, morbida e levigata.