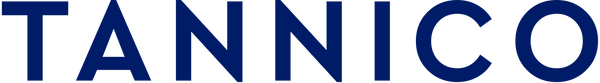Produttori del Barbaresco: l’unione fra umano e divino

Se c’è un posto dove sacro e profano coincidono, quello è il comune di Barbaresco, Piemonte. Già, perché, come dimostra la storia della sua cooperativa più famosa, i Produttori del Barbaresco, le differenze fra divino e umano si assottigliano se da entrambe le parti l'obiettivo è lo stesso: un vino perfetto, nato da uve Nebbiolo come il cugino Barolo, ma coltivato su un terreno completamente differente.
Se da una parte il Barolo viene considerato l’anima “maschile” del Nebbiolo, ottenuta da terreni in prevalenza argillosi, il Barbaresco ne rappresenta il lato “femminile”, più gentile grazie al fondo sabbioso in cui affondano le radici delle uve Nebbiolo, così estese (anche 7 metri) da risultare fra le più lunghe in tutto il mondo del vino.
Nonostante questa distinzione sia netta e conosciuta da tutti oggi, fino alla fine del 19esimo secolo quasi tutte le parcelle Nebbiolo delle Langhe venivano destinate al Barolo. Del Barbaresco neanche il nome.
Questo fino al 1894, anno in cui Domizio Favazza, preside della Regia Scuola Enologica di Alba, raduna a Barbaresco (si trattava bene, viveva nel Castello) nove tra agricoltori e proprietari per fondare le Cantine Sociali del Barbaresco. Così, per la prima volta, al Barbaresco vengono dati un nome e un luogo.

Per 30 anni la cooperativa fa risplendere il nome del Barbaresco, ma con l’arrivo del fascismo e dell’autarchia la Cantina Sociale chiude. Molti dei terreni coltivati a vite vengono infatti riseminati e convertiti in campi di frumento.
Il provvidenziale aiuto divino, dicevamo, arriva nel 1958. Cioè quando il parroco del paese, Don Fiorino Marengo, per tutelare i contadini dal mercato incerto delle uve, ma anche per riprendere in mano l’opera iniziata da Domizio Favazza, riunisce 19 viticoltori sotto un’unica cooperativa: i Produttori del Barbaresco. Qui, inizia la storia di rivalsa di un vino ignorato per secoli, dal carattere più gentile del Barolo, ma ugualmente profondo e appagante.
Oggi quei Produttori sono più di 50, per un totale di 110 ettari coltivati esclusivamente a Nebbiolo. E qui arriviamo al dunque: solo le uve giudicate più idonee all’invecchiamento diventano Barbaresco DOCG. Se un’annata o una parcella non dovesse convincere, ci si limiterà a farne comunque un ottimo Nebbiolo.
Ma nel caso in cui l’annata sia ottima, il Barbaresco non solo si fa Riserva, quindi passa dai canonici 2 a ben 4 anni di affinamento, ma prende anche il nome di uno dei 9 migliori Cru della denominazione, 9 sottozone vocate, ognuna con la propria esposizione, terreno e microclima. E per scoprire uno per uno questi Grand Cru, c’è solo un modo: prendere in esempio un’annata memorabile, tipo il 2015, e muoverci passo dopo passo fra un vigneto e l’altro di questi leggendari 9.

Prendi il Pora, uno dei più vicini al fiume Tanaro, e anche uno dei più “femminili” e propri del Barbaresco grazie al sorso agile e la chiusura sul tannino; oppure l’Asili, posto nel bel mezzo della zona di denominazione a sfoggiare una personalità spiccata e un sapore intenso. Proseguendo tra i vigneti più occidentali, quindi i meno baroleggianti, arriviamo al Rio Sordo, un’ottima via di mezzo fra i due qui sopra, maturo al frutto ma comunque soffice nei movimenti al palato.
Si passa poi al Pajè, rappresentato da un rosso di grande caratura aromatica e un finale persistente, un tripudio di eleganza. Salendo pian piano sulla collina, arriviamo ora sul punto più alto (circa 300 metri s.l.m) del Barbaresco, rappresentato egregiamente dai due cru Rabajà e Muncagota: il primo è uno dei più famosi, grazie allo spessore e alla chiusura quanto mai appagante, il secondo invece mostra un naso di ciliegia e spezie che lo rende uno dei più fruttati nell’aroma, per quando molto secco al sorso.
Chiude il gran consiglio dei 9 cru la cosiddetta “Triade del tannino”, ovvero i tre cru più orientali di Barbaresco, più argillosi e quindi più baroleggianti. Si tratta di Ovello, quindi grandi note di caffè e un tannino teso, vibrante; Montefico, che oltre all’aroma aggiunge anche un gran corpo e infine il Montestefano, per soddisfare i palati più spessi e severi, ma anche complessi e strutturati a livelli epici. Forse il più indicato per l’invecchiamento.
Se a Barbaresco il sacro e profano vanno a braccetto, l’Enoteca Regionale non poteva che stare in una chiesa sconsacrata, l’ex Confraternita di San Donato nella piazzetta del paesino. Qui, i vini migliori delle colline circostanti vengono esposti (e bevuti) sotto affreschi religiosi del ‘400. Perché a Barbaresco il vino è sia Sangue di Cristo che opera mortale, sia virtù che vizio, per ricordare a tutti che il vero Paradiso è quello che uno cerca tutti i giorni. E a volte, come in questo caso, lo trova.