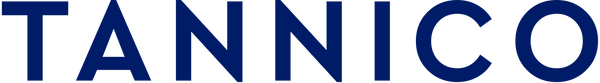La riscoperta dei vitigni autoctoni, dal Raboso all'Erbamat
Vitigni Rari Riscoperti: Il Rinascimento Enologico tra Italia e Francia
Un viaggio alla scoperta dei tesori ampelografici dimenticati che stanno vivendo una seconda vita

Indice dei contenuti
- Introduzione
- Il fenomeno della riscoperta
- I vitigni rari italiani che stanno rinascendo
- I vitigni rari francesi che stanno rinascendo
- Caratteristiche organolettiche e potenziale enologico
- I pionieri della riscoperta
- Degustare i vitigni rari: consigli per l'appassionato
- Il futuro dei vitigni rari
- Conclusione
Introduzione
C'è qualcosa di profondamente affascinante nei vitigni dimenticati, in quelle uve che per secoli hanno caratterizzato territori e tradizioni, per poi scomparire quasi del tutto dalle nostre tavole. Come antichi manoscritti ritrovati in una soffitta polverosa, questi vitigni raccontano storie di un passato enologico ricco e variegato, che rischiava di essere perduto per sempre.
Negli ultimi anni, però, stiamo assistendo a quello che potremmo definire un vero e proprio Rinascimento enologico. Viticoltori appassionati, enologi visionari e ricercatori tenaci stanno riportando alla luce questi tesori ampelografici, ridando vita a varietà che sembravano destinate all'oblio. Un fenomeno che sta interessando in modo particolare due paesi dalla straordinaria tradizione vinicola: Italia e Francia.
Il nostro Paese, con il suo patrimonio di oltre 500 vitigni autoctoni ufficialmente riconosciuti, rappresenta un caso unico al mondo per biodiversità viticola. La Francia, pur basando l'80% della sua produzione su una decina di vitigni, nasconde nelle sue regioni varietà rare di straordinario interesse. In entrambi i casi, stiamo assistendo a un ritorno alle origini, a una riscoperta delle radici più profonde della cultura enologica.
Ma perché proprio ora? Cosa ha innescato questo rinnovato interesse per i vitigni rari? Le ragioni sono molteplici e si intrecciano tra loro. Il cambiamento climatico ha reso vantaggiose caratteristiche un tempo considerate svantaggiose, come la maturazione tardiva o l'elevata acidità. La ricerca di unicità da parte dei consumatori ha spinto i produttori a differenziarsi, riscoprendo varietà dimenticate. E non ultimo, una nuova consapevolezza culturale ha portato a valorizzare il patrimonio ampelografico come espressione autentica di un territorio.
In questo articolo, vi guiderò in un viaggio affascinante tra vigneti nascosti, cantine storiche e bottiglie rare. Scopriremo insieme quali sono i vitigni che stanno vivendo una seconda vita, quali caratteristiche li rendono speciali e perché rappresentano non solo un ritorno al passato, ma anche una scommessa sul futuro del vino.
Preparate i calici: stiamo per degustare la storia che rinasce.
Il fenomeno della riscoperta
Perché alcuni vitigni, un tempo diffusi e apprezzati, sono stati abbandonati fino quasi a scomparire? La risposta a questa domanda ci aiuta a comprendere meglio il valore della loro riscoperta.
Nel corso dei secoli, la viticoltura ha seguito logiche diverse da quelle attuali. L'agricoltura del passato privilegiava la quantità sulla qualità, la facilità di coltivazione sulla complessità aromatica, la resistenza alle malattie sulla peculiarità espressiva. In un'epoca in cui il vino era principalmente nutrimento quotidiano, i vitigni che producevano poco o che richiedevano cure particolari venivano progressivamente abbandonati.
La fillossera, quell'insetto devastatore che alla fine dell'Ottocento distrusse gran parte dei vigneti europei, rappresentò un punto di svolta drammatico. Nella ricostruzione post-fillossera, molti viticoltori scelsero di piantare varietà più produttive o più richieste dal mercato, accelerando l'abbandono di vitigni locali meno conosciuti.
Nel corso del Novecento, poi, la standardizzazione dei gusti e la globalizzazione del mercato hanno ulteriormente ridotto la biodiversità viticola. I cosiddetti vitigni internazionali – Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc – hanno conquistato terreno in ogni angolo del pianeta, spesso a scapito delle varietà autoctone.
Ma cosa sta cambiando oggi? Quali fattori stanno contribuendo alla rinascita di questi vitigni dimenticati?
Il primo, paradossalmente, è proprio il cambiamento climatico. Molti vitigni furono abbandonati perché maturavano con difficoltà nei climi più freschi del passato. Oggi, con l'innalzamento delle temperature, queste stesse varietà trovano condizioni ideali per esprimere il loro potenziale. L'Erbamat in Lombardia, ad esempio, un tempo penalizzato dalla sua maturazione tardiva, oggi è apprezzato proprio per la sua capacità di mantenere acidità e freschezza in stagioni sempre più calde.
Un secondo fattore è la ricerca di unicità e identità territoriale. In un mondo dove i vini tendono ad assomigliarsi sempre più, i consumatori più attenti cercano esperienze autentiche e distintive. I vitigni autoctoni, con il loro legame profondo con un territorio specifico, rispondono perfettamente a questa esigenza. Non è un caso che molti ristoranti stellati e wine bar di tendenza stiano arricchendo le loro carte con vini da vitigni rari e poco conosciuti.
C'è poi il lavoro fondamentale di ricercatori e produttori appassionati, veri e propri "Indiana Jones" dell'ampelografia, che hanno dedicato anni alla ricerca e al recupero di varietà quasi estinte. Figure come Emilio Bulfon in Friuli o Gianpaolo Girardi in Trentino in Italia, o i fratelli Aubry in Champagne, hanno letteralmente salvato dall'estinzione vitigni che oggi tornano a raccontare storie dimenticate.
Non va sottovalutato, infine, il ruolo delle istituzioni e delle università. Progetti di ricerca, banche del germoplasma, studi sul DNA delle varietà antiche hanno fornito strumenti scientifici per identificare, catalogare e valorizzare questo patrimonio genetico. L'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano in Italia o l'INRA in Francia hanno contribuito in modo determinante a questa riscoperta.
Il risultato è un fenomeno che va ben oltre la semplice moda passeggera. La riscoperta dei vitigni rari rappresenta un ritorno consapevole alle radici, una valorizzazione della diversità come ricchezza, un modo nuovo di guardare al vino non solo come prodotto, ma come espressione culturale di un territorio e della sua storia.
I vitigni rari italiani che stanno rinascendo
L'Italia è un vero e proprio scrigno di biodiversità viticola. Con oltre 500 vitigni autoctoni ufficialmente riconosciuti, il nostro Paese vanta un patrimonio ampelografico che nessun'altra nazione al mondo può eguagliare. Questa ricchezza, frutto di secoli di storia e di un territorio estremamente variegato, rischiava però di impoverirsi drasticamente.
Fortunatamente, negli ultimi anni stiamo assistendo a una vera e propria rinascita di molti vitigni che sembravano destinati all'oblio. Un fenomeno che attraversa l'Italia da nord a sud, ridisegnando la mappa enologica della penisola e offrendo ai wine lovers esperienze di degustazione uniche e sorprendenti.
Nord Italia: tesori alpini e prealpini
Il Nord Italia è particolarmente ricco di vitigni rari che stanno vivendo una seconda giovinezza. Partiamo dalla Lombardia, dove l'Erbamat sta conquistando un posto d'onore nella produzione di Franciacorta. Questo vitigno a bacca bianca, più tardivo dello Chardonnay e del Pinot, era stato quasi completamente abbandonato a causa della sua difficoltà di maturazione nei climi più freschi del passato. Oggi, con il riscaldamento globale, la sua elevata carica acida è diventata un vantaggio prezioso, contribuendo alla freschezza delle bollicine bresciane. Non a caso, il disciplinare della Franciacorta ne ammette ora l'utilizzo fino al 10% nell'uvaggio.
In Piemonte, il Timorasso rappresenta una delle storie di rinascita più affascinanti. Questo vitigno a bacca bianca dei colli tortonesi, poco docile e di difficile coltivazione, negli anni Ottanta era caduto nell'oblio, tanto più in una terra tradizionalmente vocata ai grandi rossi. Grazie all'ostinazione di un personaggio visionario come Walter Massa, oggi il Timorasso occupa il posto che gli spetta tra i grandissimi bianchi italiani. I suoi cru più emblematici, come Sterpi e Costa del Vento, regalano vini sapidi, inconfondibili e con una grande longevità, capaci di sfidare il tempo come pochi bianchi sanno fare.
Spostandoci in Trentino, incontriamo la Nosiola, un'uva bianca fragrante e duttile che, tra tanti vitigni internazionali, mantiene alta la bandiera dell'autoctonia. Da questa varietà nasce uno dei migliori vini dolci italiani, il Vino Santo trentino, ottimo per carattere e freschezza soprattutto nella versione di Giovanni Poli Santa Massenza.
Il Veneto ci offre il Raboso del Piave, uno dei vitigni più antichi della regione, rustico e apparentemente indomabile, con un ciclo vegetativo molto lungo. Dà vita a vini dal bouquet intenso e complesso, che possono invecchiare bene. Tra le interpretazioni più interessanti ci sono quelle dell'azienda agricola Cecchetto a Tezze di Piave, che produce anche una originale versione spumantizzata, il Rosa Bruna, e un Raboso Passito con precisi sentori di marasca e datteri.
Il Friuli è forse la regione che più di tutte ha saputo preservare e valorizzare i suoi vitigni autoctoni. Merito di pionieri come Emilio Bulfon che, con la proverbiale caparbietà friulana, ha strappato a morte certa delle vere e proprie "reliquie" viticole. Nell'area pedemontana della provincia di Pordenone, in località come Valeriano, Costabeorchia, Campeis e Castelnuovo del Friuli, Bulfon ha riscoperto e salvato varietà come il Cividin, il Forgiarin, il Cjanòrie, lo Sciaglìn, il Piculit Neri, il Pignul, il Cordenòs e l'Ucelut.
Centro Italia: tra Appennini e coste tirreniche
Nel Centro Italia, la Toscana ci regala la storia del Foglia Tonda, un "figlio del Sangiovese" caduto in disuso da oltre un secolo. La sua rinascita si deve a Donatella Cinelli Colombini, che lo ha riscoperto e valorizzato utilizzandolo per il Cenerentola DOC Orcia. Dopo un inizio difficile, oggi il Foglia Tonda, in uvaggio con il Sangiovese, sta salendo le classifiche internazionali, dimostrando come anche in una regione dominata da vitigni affermati ci sia spazio per riscoprire varietà dimenticate.
Nel Lazio, il Cesanese sta vivendo una vera e propria renaissance. Questo vitigno a bacca rossa, espressione autentica del territorio laziale, sta finalmente ottenendo l'attenzione che merita, grazie a produttori che ne hanno saputo valorizzare le potenzialità, creando vini di carattere e personalità.
Sud Italia e Isole: il sole che risveglia antiche varietà
Il Sud Italia, con il suo clima mediterraneo e la sua millenaria tradizione viticola, è un terreno particolarmente fertile per la riscoperta di vitigni autoctoni. In Campania, il Biancolella di Ischia e l'Asprinio di Aversa rappresentano due esempi emblematici. Quest'ultimo, descritto da Mario Soldati come "grande, piccolo vino", è caratterizzato da una tipica coltivazione ad alberata, un sistema antico che crea un paesaggio viticolo unico e affascinante.
Il Molise, piccola regione spesso trascurata nella geografia enologica italiana, sta trovando nella Tintilia un simbolo di identità e rinascita. Questo vitigno a bacca rossa, riscoperto come emblema dell'autenticità vinicola molisana, sta conquistando l'interesse di appassionati e critici.
In Sardegna, il Nasco, antichissimo vitigno a bacca bianca, ha trovato nell'entroterra di Cagliari il terroir ideale per esprimere le sue potenzialità. Dopo anni di oblio, oggi questa varietà sta tornando a raccontare la storia millenaria dell'enologia sarda.
Questi sono solo alcuni esempi di un fenomeno che sta ridisegnando la mappa del vino italiano. Ogni regione, ogni territorio sta riscoprendo le proprie radici ampelografiche, offrendo ai wine lovers la possibilità di esplorare un patrimonio di biodiversità unico al mondo. Un viaggio che ci porta a degustare non solo vini, ma storie, tradizioni e paesaggi, in un calice che racchiude l'essenza più autentica dell'Italia.
I vitigni rari francesi che stanno rinascendo
La Francia, patria di alcuni dei vini più celebri al mondo, è spesso associata a vitigni ormai diventati internazionali come Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Eppure, anche il paese d'Oltralpe nasconde un tesoro di biodiversità viticola che sta tornando alla luce.
Su circa 210 vitigni autoctoni francesi, meno di una decina coprono oltre due terzi della superficie impiantata a vigna. Bastano addirittura solo tre vitigni – Merlot, Grenache Noir e Ugni Blanc – per coprire un terzo della superficie vitata francese. Ma negli angoli meno conosciuti delle regioni vinicole francesi, lontano dai riflettori delle denominazioni più celebri, alcuni produttori stanno riscoprendo e valorizzando varietà dimenticate, creando vini di straordinaria originalità e carattere.
Champagne: le bollicine rare
La Champagne, regione simbolo delle bollicine di lusso, è forse l'esempio più emblematico di questa tendenza. Se tutti conosciamo il classico trittico Chardonnay-Pinot Noir-Pinot Meunier, pochi sanno che il disciplinare della denominazione ammette anche altri quattro vitigni: Pinot Blanc, Pinot Gris (localmente chiamato Fromenteau), Arbane e Petit Meslier.
L'Arbane è un vitigno molto antico e originario proprio della Champagne, in particolare della zona dell'Aube. Dona vini delicati e floreali, con alcool abbastanza presente e dall'acidità sostenuta che garantisce un buon potenziale di invecchiamento. A causa della sensibilità alla peronospora, di una maturazione tardiva e di una buccia spessa che comporta qualche difficoltà in più al momento della pressatura, era stato a lungo abbandonato tanto da rischiarne l'estinzione: nel 1998 se ne contava un solo ettaro piantato in tutta la Champagne. Oggi, nella Champagne del nuovo millennio, sta registrando una lentissima ma costante rinascita.
Il Petit Meslier è un vitigno originario dell'est della Francia, nato da un incrocio naturale tra i vitigni Savagnin e Gouais. Predilige suoli argillo-calcarei e quando arriva a maturazione mostra acini di colore dorato. Il vino che ne deriva ha una buona struttura ed una intensa componente aromatica fruttata molto elegante. Viene riscoperto per la sua spiccata acidità, una risorsa sempre più rara e apprezzata nella Champagne del XXI secolo, soprattutto in un'epoca di cambiamenti climatici.
Pionieri di questa riscoperta sono stati i fratelli Pierre e Philippe Aubry che, già dai primi anni Novanta, si riproposero di reintrodurre questi vitigni rari nelle loro cuvée. Oggi, produttori come Érick Schreiber, Laherte Frères e Olivier Horiot stanno seguendo questa strada, creando Champagne di straordinaria originalità e complessità.
Jura: il ritorno del Savagnin
Lo Jura, piccola regione vinicola incastonata tra la Borgogna e la Svizzera, è un altro esempio di territorio che sta vivendo una rinascita grazie alla riscoperta di vitigni autoctoni. Il Savagnin è un vitigno bianco francese originario della vasta regione che copre il nord est della Francia e il sud est della Germania. Coltivato quasi esclusivamente in Jura, di cui ne è l'immagine e la bandiera, predilige suoli a prevalenza calcarea dove esprime aromaticità, complessità e una sferzante acidità.
Il Savagnin è utilizzato tradizionalmente per la produzione del Vin Jaune, un vino unico al mondo, simile allo Sherry, che matura sotto un velo di lieviti per almeno sei anni e tre mesi, e del Vin de Paille, un vino dolce e concentrato ottenuto da uve appassite su graticci di paglia.
Questo vitigno sta vivendo una seconda giovinezza in termini di apprezzamento, non perché fosse stato precedentemente abbandonato, ma perché riscoperto a livello gustativo e commerciale. La svolta è avvenuta tra la fine degli anni '90 e gli inizi del nuovo millennio, quando alcuni produttori decisero di vinificarlo in vini fermi secchi senza metodo ossidativo, colmando le botti durante l'affinamento. Nascono così i vini "ouillés" (letteralmente "colmati"), dove il Savagnin dona vini bianchi di buona struttura e freschezza, dominati da note minerali, di agrumi e fiori bianchi.
Savoia: la Mondeuse, rosso alpino
Spostandoci nelle Alpi francesi, incontriamo la Mondeuse, uno dei più storici e distintivi vitigni della Savoia. Questo vitigno a bacca rossa dona vini dal colore rubino intenso con sfumature violacee, con un frutto succoso, che esprime note di violetta, lampone, prugna e cassis, accompagnate da una distintiva nota speziata di pepe bianco che riporta eleganza e freschezza nel bicchiere.
Il corpo è agile ma non magro, i tannini eleganti e ben si adattano ad un affinamento in legno. Un vino che, per le sue caratteristiche, potrebbe essere descritto come un compromesso ben riuscito tra le caratteristiche di un Gamay del Beaujolais e un Pinot Noir della Borgogna.
Valle del Rodano: il Viognier risorto
Il Viognier è originario della regione della Valle del Rodano e rappresenta una delle storie di rinascita più emblematiche del panorama viticolo francese. Questo vitigno, passato in secondo piano per molto tempo, sta riscuotendo negli ultimi anni un nuovo successo grazie al suo profilo organolettico unico.
Si tratta di un'uva cosiddetta aromatica per via della complessità e intensità dei profumi che sprigiona. Le note che si riconoscono più di frequente sono quelle floreali, di caprifoglio, camomilla e fiori bianchi, ma soprattutto le note fruttate di albicocca e mango, insieme a ricordi di mandorla amara, miele e marzapane.
La denominazione del Viognier per eccellenza è Condrieu, nel Rodano settentrionale, ma è un vitigno che ha viaggiato e ora si trovano esempi molto interessanti anche in Australia e Sudafrica, segno della sua versatilità e del crescente apprezzamento a livello internazionale.
Questi sono solo alcuni esempi di un fenomeno che sta interessando diverse regioni vinicole francesi. Come in Italia, anche in Francia la riscoperta dei vitigni rari rappresenta non solo un ritorno alle tradizioni, ma anche un modo per affrontare le sfide del futuro, in particolare quelle legate al cambiamento climatico. Varietà un tempo considerate marginali si rivelano oggi preziose per la loro capacità di adattamento e per le loro caratteristiche organolettiche uniche, offrendo ai wine lovers esperienze di degustazione autentiche e sorprendenti.
Caratteristiche organolettiche e potenziale enologico
Ciò che rende davvero affascinanti i vitigni rari riscoperti non è solo la loro storia o la loro rarità, ma soprattutto il loro profilo organolettico unico e il loro potenziale enologico. Questi vitigni offrono esperienze di degustazione che si discostano dai canoni più conosciuti, regalando sensazioni inaspettate e sorprendenti.
Profili gustativi distintivi
Uno degli aspetti più interessanti dei vitigni rari è la loro capacità di esprimere caratteristiche organolettiche che non troviamo nei vitigni più diffusi. Prendiamo ad esempio il Timorasso piemontese: questo vitigno bianco regala vini di straordinaria mineralità, con note di pietra focaia, idrocarburi e frutta a polpa bianca, sostenuti da un'acidità vibrante e da una struttura che permette lunghi affinamenti. Un profilo che si avvicina più ai grandi Riesling tedeschi che ai bianchi italiani tradizionali.
Il Foglia Tonda toscano, invece, offre un bouquet olfattivo dominato da note di frutti di bosco, spezie e un caratteristico sentore balsamico, con tannini eleganti e una freschezza che bilancia perfettamente la componente alcolica. Un rosso che sa essere potente senza risultare pesante, ideale complemento al più celebre Sangiovese.
In Francia, l'Arbane della Champagne si distingue per la sua delicatezza floreale, con note di fiori bianchi, agrumi e una sottile vena minerale, sostenuta da un'acidità vibrante che la rende perfetta per la spumantizzazione. Il Savagnin dello Jura, soprattutto nella sua versione ossidativa, sviluppa un bouquet complesso di frutta secca, spezie, noce e un inconfondibile sentore di curry, con una persistenza in bocca che può durare minuti.
Adattabilità al cambiamento climatico
Un aspetto sempre più rilevante nella valutazione del potenziale enologico di un vitigno è la sua capacità di adattarsi al cambiamento climatico. E qui, paradossalmente, molti vitigni rari mostrano caratteristiche che li rendono particolarmente preziosi per il futuro della viticoltura.
L'Erbamat lombardo, ad esempio, con la sua maturazione tardiva e la sua capacità di mantenere acidità anche in stagioni calde, si sta rivelando un alleato prezioso per mantenere freschezza e longevità nei Franciacorta. Analogamente, il Petit Meslier della Champagne, con la sua naturale acidità elevata, rappresenta una risorsa importante in un contesto di innalzamento delle temperature.
Potenziale di invecchiamento
Un altro aspetto sorprendente di molti vitigni rari è il loro eccellente potenziale di invecchiamento. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sono solo i grandi vitigni internazionali a produrre vini capaci di sfidare il tempo.
Il Timorasso, ad esempio, può evolvere positivamente per 10-15 anni, sviluppando complessità aromatiche straordinarie. Il Raboso del Piave veneto, con la sua struttura tannica importante e la sua acidità sostenuta, può migliorare per decenni, ammorbidendosi e acquisendo sfumature terziarie affascinanti.
In Francia, il Savagnin dello Jura, soprattutto nella versione Vin Jaune, è uno dei bianchi più longevi al mondo, capace di evolversi positivamente per 50 anni e oltre. La Mondeuse della Savoia, con i suoi tannini eleganti e la sua freschezza, può sorprendere per la sua capacità di invecchiamento, soprattutto nelle annate migliori.
Versatilità nell'utilizzo
Infine, molti vitigni rari si distinguono per la loro versatilità, che permette di ottenere stili di vino molto diversi a partire dalla stessa uva. Il Savagnin, ad esempio, può dare vita a vini secchi non ossidativi (ouillés), a vini ossidativi (Vin Jaune), a vini dolci da uve appassite (Vin de Paille) e persino a spumanti, mostrando volti completamente diversi a seconda della vinificazione.
Analogamente, il Raboso del Piave può essere vinificato in rosso secco, in versione passita o spumantizzata, offrendo un'ampia gamma di possibilità espressive. L'Asprinio di Aversa campano si presta sia alla produzione di vini fermi freschi e sapidi, sia alla spumantizzazione con metodo classico o Charmat.
In conclusione, le caratteristiche organolettiche e il potenziale enologico dei vitigni rari riscoperti non sono solo un patrimonio da preservare per ragioni storiche o culturali, ma rappresentano una risorsa viva e dinamica per il futuro del vino, capace di offrire esperienze di degustazione uniche e di rispondere alle sfide che il settore vitivinicolo dovrà affrontare nei prossimi decenni.
I pionieri della riscoperta
Dietro ogni vitigno raro che torna a vivere c'è sempre una storia di passione, tenacia e visione. Sono i pionieri della riscoperta, figure che hanno dedicato anni, talvolta decenni, a salvare dall'estinzione varietà dimenticate, credendo nel loro potenziale quando nessun altro ci credeva. Veri e propri "Indiana Jones" dell'ampelografia, hanno esplorato vigneti abbandonati, studiato antichi testi, sperimentato tecniche di vinificazione, tutto per riportare alla luce un patrimonio che rischiava di scomparire per sempre.
I salvatori italiani
In Italia, uno dei nomi che merita di essere ricordato è quello di Emilio Bulfon, benemerito della viticoltura friulana. Con la proverbiale caparbietà dei "furlani", ha strappato a morte certa delle vere e proprie "reliquie" viticole nell'area pedemontana della provincia di Pordenone. La località dove ha trovato un miracoloso approdo questa mitica "Arca di Noè" è Valeriano, paesino di poche anime nel comune di Pinzano al Tagliamento, diventato assieme a Costabeorchia, Campeis e Castelnuovo del Friuli il simbolo stesso della rinascita enoica del Friuli più autentico.
In Piemonte, Walter Massa è il nome indissolubilmente legato alla rinascita del Timorasso. Negli anni '80, quando questo vitigno era praticamente scomparso dai colli tortonesi, Massa ha creduto nelle sue potenzialità, piantando nuovi vigneti e sperimentando tecniche di vinificazione. Il risultato è stato straordinario: oggi il Timorasso è considerato uno dei grandi bianchi italiani, capace di sfidare il tempo e di esprimere in modo unico il terroir di origine.
In Toscana, Donatella Cinelli Colombini ha avuto un ruolo fondamentale nella riscoperta del Foglia Tonda, un "figlio del Sangiovese" caduto in disuso da oltre un secolo. Utilizzandolo per il Cenerentola DOC Orcia, ha dimostrato le potenzialità di questo vitigno che, dopo un inizio difficile, oggi sta salendo le classifiche internazionali.
I visionari francesi
In Francia, i fratelli Pierre e Philippe Aubry sono stati tra i primi a credere nel potenziale dei vitigni rari della Champagne. Già dai primi anni Novanta si riproposero di reintrodurre fromenteau, arbane, pinot blanc e petit meslier nelle loro cuvée, creando Champagne di straordinaria originalità e complessità. Oggi, produttori come Érick Schreiber, Laherte Frères e Olivier Horiot stanno seguendo questa strada, contribuendo alla rinascita di un patrimonio ampelografico che sembrava destinato all'oblio.
Nella Valle del Rodano, Georges Vernay è considerato il salvatore del Viognier, vitigno che negli anni '60 era ridotto a meno di 10 ettari in tutta la Francia. Grazie al suo lavoro nella denominazione di Condrieu, oggi il Viognier è tornato a splendere, diffondendosi anche in altre regioni del mondo.
Il ruolo delle istituzioni
Accanto a questi pionieri individuali, non va dimenticato il ruolo fondamentale delle istituzioni e dei centri di ricerca. L'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano in Italia, l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) in Francia, l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige in Trentino hanno contribuito in modo determinante alla conservazione e allo studio dei vitigni autoctoni.
Le banche del germoplasma, vere e proprie "arche di Noè" genetiche, conservano migliaia di varietà di vite, garantendo che anche quelle non più coltivate commercialmente possano essere preservate per le generazioni future. La ricerca sul DNA delle varietà antiche ha permesso di identificare parentele insospettate e di ricostruire la storia evolutiva dei vitigni, fornendo strumenti scientifici per valorizzare questo patrimonio.
Grazie a questi pionieri, oggi possiamo degustare vini che raccontano storie dimenticate, che esprimono terroir unici, che offrono esperienze sensoriali inaspettate. E possiamo guardare al futuro della viticoltura con maggiore fiducia, sapendo che la biodiversità viticola, lungi dall'essere un relitto del passato, rappresenta una risorsa preziosa per affrontare le sfide che ci attendono.
Degustare i vitigni rari: consigli per l'appassionato
Avvicinarsi al mondo dei vitigni rari è come intraprendere un viaggio in territori inesplorati: affascinante, sorprendente, talvolta sfidante. Per chi è abituato ai profili gustativi dei vitigni più diffusi, l'incontro con queste varietà dimenticate può rappresentare una rivelazione, ma richiede anche un approccio aperto e curioso. Ecco alcuni consigli per apprezzare al meglio questi tesori enologici.
Come approcciarsi a questi vini
Il primo consiglio è quello di abbandonare i preconcetti. I vitigni rari spesso offrono profili organolettici che si discostano dai canoni più conosciuti, con caratteristiche che possono sorprendere o persino spiazzare al primo assaggio. L'acidità pronunciata di un Timorasso, le note ossidative di un Savagnin dello Jura, i tannini rustici di un Raboso del Piave richiedono un palato disposto a esplorare nuovi territori gustativi.
È utile informarsi prima della degustazione sulla storia del vitigno, sulle sue caratteristiche e sul territorio di provenienza. Conoscere il contesto aiuta a comprendere meglio ciò che si sta degustando e ad apprezzarne le peculiarità. Molti produttori di vitigni rari sono veri appassionati, pronti a raccontare con entusiasmo la storia delle loro vigne e dei loro vini: approfittatene per arricchire l'esperienza di degustazione.
Abbinamenti gastronomici consigliati
I vitigni rari offrono spesso possibilità di abbinamento gastronomico originali e stimolanti. Ecco alcuni suggerimenti per i vitigni che abbiamo esplorato in questo articolo:
Il Timorasso piemontese, con la sua struttura importante e la sua mineralità, si sposa magnificamente con piatti di pesce strutturati come un rombo al forno, ma anche con formaggi di media stagionatura o carni bianche.
L'Erbamat lombardo, utilizzato nei Franciacorta, con la sua freschezza e acidità, è perfetto con crostacei, ostriche e piatti a base di pesce crudo.
Il Savagnin dello Jura, soprattutto nella versione ossidativa, trova un abbinamento classico con il Comté, formaggio tipico della regione, ma si sposa bene anche con piatti a base di funghi, pollame e frutti di mare.
Temperature di servizio
La temperatura di servizio è un elemento cruciale per apprezzare al meglio le caratteristiche di un vino, e questo vale ancora di più per i vitigni rari, che spesso presentano profili aromatici complessi e delicati.
Per i bianchi strutturati come il Timorasso o il Savagnin, è consigliabile una temperatura di servizio intorno ai 12-14°C, più alta rispetto ai bianchi leggeri. Questo permette di apprezzare pienamente la complessità aromatica e la struttura di questi vini.
I bianchi più freschi e aromatici come la Nosiola o il Prié Blanc possono essere serviti più freschi, intorno ai 10-12°C, per esaltarne la freschezza e la vivacità.
Per quanto riguarda gli Champagne con vitigni rari come Arbane e Petit Meslier, la temperatura ideale è di 8-10°C, leggermente più alta rispetto agli Champagne tradizionali, per permettere ai profumi più delicati di esprimersi.
Occasioni ideali per degustarli
I vini da vitigni rari meritano occasioni che permettano di apprezzarne appieno le caratteristiche e la storia. Sono perfetti per cene con appassionati di vino, dove possono diventare spunto di conversazione e scoperta condivisa.
Rappresentano anche un'ottima scelta per celebrare occasioni speciali in modo originale, offrendo un'alternativa ai vini più conosciuti e prevedibili.
In conclusione, avvicinarsi ai vitigni rari richiede curiosità, apertura mentale e voglia di esplorare. Ma le soddisfazioni che possono offrire sono straordinarie: non solo esperienze gustative uniche, ma anche la sensazione di contribuire alla preservazione di un patrimonio culturale inestimabile, fatto di biodiversità, tradizioni e storie che meritano di essere raccontate e vissute attraverso un calice di vino.
Il futuro dei vitigni rari
La riscoperta dei vitigni rari non è solo un affascinante viaggio nel passato, ma rappresenta anche una scommessa sul futuro. Questi tesori ampelografici, salvati dall'estinzione grazie alla passione di produttori visionari, potrebbero infatti giocare un ruolo fondamentale nell'evoluzione della viticoltura nei prossimi decenni. Vediamo quali sono le prospettive e le sfide che li attendono.
Prospettive di diffusione
La tendenza attuale mostra segnali incoraggianti per la diffusione dei vitigni rari. Sempre più produttori, anche di dimensioni significative, stanno investendo nel recupero di varietà dimenticate, riconoscendone il valore non solo culturale ma anche commerciale.
In Italia, regioni come il Friuli, il Trentino, la Campania e la Sardegna stanno facendo della biodiversità viticola un elemento distintivo della loro identità enologica. In Francia, anche denominazioni prestigiose come la Champagne stanno riscoprendo il valore dei vitigni storici, integrandoli nelle loro produzioni.
Potenziale commerciale
Dal punto di vista commerciale, i vitigni rari rappresentano un'opportunità interessante in un mercato sempre più saturo e competitivo. In un contesto in cui i consumatori sono alla ricerca di esperienze autentiche e distintive, i vini da vitigni rari offrono una proposta di valore unica.
La narrazione che accompagna questi vini – fatta di storie di riscoperta, di legami profondi con il territorio, di tradizioni salvate dall'oblio – rappresenta un elemento di marketing potentissimo, capace di creare un forte coinvolgimento emotivo.
Importanza per la biodiversità viticola
Al di là delle considerazioni commerciali, la riscoperta dei vitigni rari ha un'importanza fondamentale per la preservazione della biodiversità viticola. Ogni varietà che scompare rappresenta una perdita irreparabile di patrimonio genetico, di conoscenze tradizionali, di possibilità espressive.
La biodiversità non è solo un valore culturale, ma anche una risorsa strategica per affrontare le sfide future. Un patrimonio genetico diversificato offre più possibilità di adattamento ai cambiamenti climatici, più resistenza alle malattie, più opzioni per rispondere all'evoluzione dei gusti e delle esigenze del mercato.
Ruolo nel contesto del cambiamento climatico
Il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più significative per la viticoltura contemporanea. L'innalzamento delle temperature, la modifica dei regimi di precipitazione, l'aumento degli eventi estremi stanno cambiando profondamente le condizioni di coltivazione della vite in molte regioni.
In questo contesto, i vitigni rari potrebbero rivelarsi preziosi alleati. Molte di queste varietà, infatti, presentano caratteristiche che le rendono particolarmente adatte ad affrontare le nuove condizioni climatiche:
Maturazione tardiva: vitigni come l'Erbamat o il Petit Meslier, che in passato faticavano a raggiungere la piena maturazione, oggi trovano condizioni più favorevoli e mantengono freschezza e acidità anche in stagioni calde.
Resistenza alla siccità: alcune varietà autoctone, soprattutto quelle originarie di regioni mediterranee, hanno sviluppato nei secoli meccanismi di adattamento a condizioni di scarsa disponibilità idrica.
In conclusione, il futuro dei vitigni rari appare promettente, non solo come curiosità per appassionati o come operazione di recupero culturale, ma come risorsa viva e dinamica per una viticoltura sostenibile, diversificata e resiliente. La loro riscoperta rappresenta un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, in un settore che ha sempre saputo reinventarsi mantenendo salde le proprie radici.
Conclusione
Il nostro viaggio alla scoperta dei vitigni rari riscoperti volge al termine, ma in realtà rappresenta solo l'inizio di un'avventura che ogni appassionato di vino può intraprendere nel proprio percorso di esplorazione enologica.
Abbiamo visto come varietà un tempo dimenticate stiano vivendo una seconda vita grazie alla passione di produttori visionari, alla curiosità di consumatori sempre più consapevoli e a un contesto che, paradossalmente, trasforma in vantaggi quelle che un tempo erano considerate criticità. Il cambiamento climatico, la ricerca di unicità, la riscoperta delle tradizioni locali stanno ridisegnando la mappa del vino, riportando alla luce tesori che rischiavano di scomparire per sempre.
In Italia, dal Timorasso piemontese al Biancolella campano, dall'Erbamat lombardo alla Tintilia molisana, questi vitigni raccontano storie di territori, di persone, di saperi tramandati attraverso generazioni. Sono l'espressione più autentica di quella straordinaria biodiversità che rende unico il patrimonio viticolo italiano.
In Francia, l'Arbane e il Petit Meslier nella Champagne, il Savagnin nello Jura, la Mondeuse in Savoia, il Viognier nella Valle del Rodano dimostrano come anche in un paese dalla forte tradizione viticola ci sia spazio per riscoprire e valorizzare varietà che sembravano destinate all'oblio.
Questi vitigni non sono solo curiosità per appassionati o operazioni nostalgiche, ma rappresentano una risorsa viva e dinamica per il futuro del vino. La loro diversità genetica, le loro caratteristiche uniche, la loro capacità di esprimere in modo autentico un territorio specifico li rendono preziosi in un mondo che rischia l'omologazione.
Come sommelier e appassionati di vino, abbiamo la responsabilità di sostenere questo movimento di riscoperta, scegliendo di degustare e far conoscere questi vini, approfondendone la storia, visitando i territori di produzione. Ogni bottiglia di vino da vitigno raro che apriamo non è solo un'esperienza sensoriale, ma un gesto che contribuisce a preservare un patrimonio culturale inestimabile.
Il Rinascimento enologico dei vitigni rari è appena iniziato, e tutti noi possiamo esserne protagonisti. Salute!
Torna su ↑